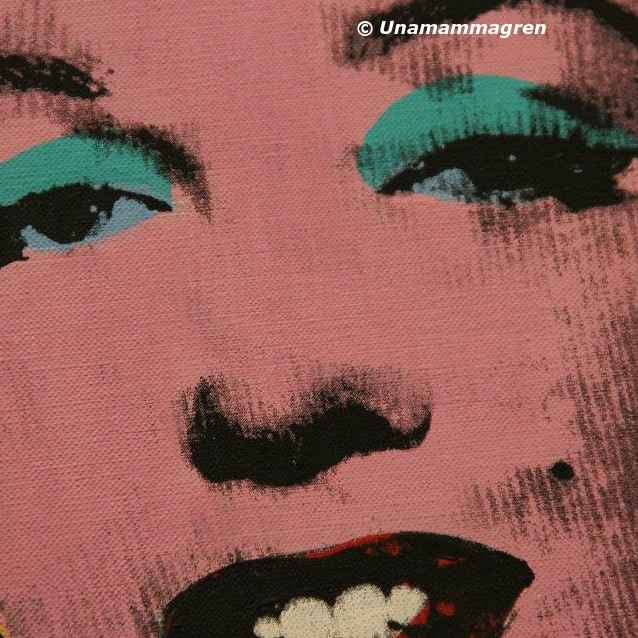È singolare come, a volte, a emozionarci siano le cose più naturali, quelle più istintive. Quelle scontate, che ci contraddistinguono come appartenenti alla nostra specie e che, in quanto tali, dovrebbero in un certo senso essere ovvie. Come un neonato quasi cieco che si fionda sul capezzolo materno “senza che nessuno gli abbia detto dov’è”. O come un bambino piccolo che muove i suoi primi passi. Il minuscolo erectus ultimo modello, in ultima analisi, non fa altro che rispondere a un istinto atavico, comune peraltro ad altre specie animali. Obbedisce, senza alcun merito, a un codice messo a punto dall’evoluzione quasi due milioni di anni fa: abbandona la quadrupedia e si alza in piedi. Spendendo, per inciso, molto più tempo – e fatica, e cadute, e bitorzoli – di quanto, in proporzione, impieghi un pulcino per spiccare il suo primo volo, o una baby zebra per lanciarsi al galoppo (non che sia colpa del microscopico umano, intendiamoci: è naturale anche tutta questa fatica).
È singolare come, a volte, a emozionarci siano le cose più naturali, quelle più istintive. Quelle scontate, che ci contraddistinguono come appartenenti alla nostra specie e che, in quanto tali, dovrebbero in un certo senso essere ovvie. Come un neonato quasi cieco che si fionda sul capezzolo materno “senza che nessuno gli abbia detto dov’è”. O come un bambino piccolo che muove i suoi primi passi. Il minuscolo erectus ultimo modello, in ultima analisi, non fa altro che rispondere a un istinto atavico, comune peraltro ad altre specie animali. Obbedisce, senza alcun merito, a un codice messo a punto dall’evoluzione quasi due milioni di anni fa: abbandona la quadrupedia e si alza in piedi. Spendendo, per inciso, molto più tempo – e fatica, e cadute, e bitorzoli – di quanto, in proporzione, impieghi un pulcino per spiccare il suo primo volo, o una baby zebra per lanciarsi al galoppo (non che sia colpa del microscopico umano, intendiamoci: è naturale anche tutta questa fatica).
Eppure noi siamo lì, con l’occhio lucido e la fotocamera in mano, ad applaudire a quelle prime passeggiatine barcollanti. Come se fossero una prerogativa speciale della nostra propria progenie, più che la naturale condizione che accomuna tutti gli animali bipedi. Come se ci fosse qualcosa di eccezionale in un cucciolo di Homo sapiens che, tra l’anno e l’anno e mezzo di vita, impara a reggersi e a spostarsi sui propri arti posteriori. O a trasformare in quelle che in italiano si chiamano parole dei suoni gutturali e disarticolati.
Forse è solo che sono proprio le cose che ci riconducono alla nostra natura più ultima, più nuda, quelle che ci emozionano e ci appagano maggiormente. Più dei falsi bisogni e delle sovrastrutture imposte dalla cultura e dai tempi. Più delle proprietà materiali, più delle esperienze strutturate e complesse. Le esperienze più semplici, più universali e “banali”, in un certo senso, sono quelle che riscuotono il consenso più unanime e incondizionato.