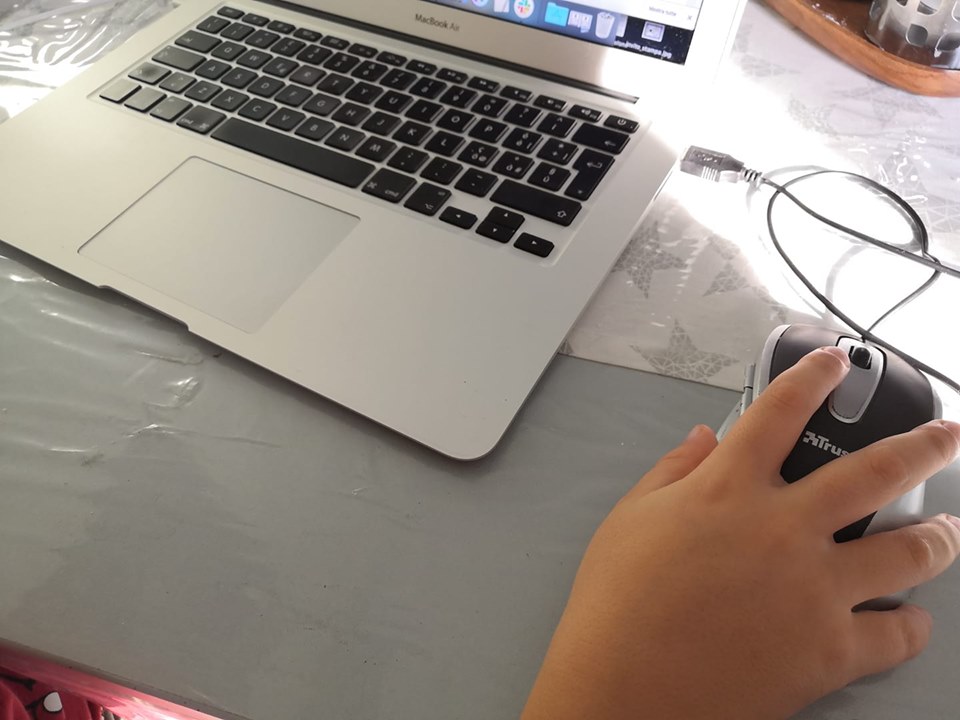Il panico con cui nei giorni scorsi noi genitori abbiamo atteso, e poi appreso, la notizia della chiusura delle scuole è stato probabilmente più intenso di quello generato dal dilagare stesso del nuovo Coronavirus. Comprensibilmente. Il problema principale, è indubbio, è rappresentato dalla conciliazione tra lavoro e famiglia, che se di solito è già una bella gatta da pelare, in tempi di chiusura prolungata delle scuole (ma non di tutto il resto, perlomeno in molte aree del Paese) diventa semplicemente un incubo senza via di uscita. C’è chi ha quattro settimane di ferie da farsi bastare per tutto l’anno, chi è precario e di fatto “non può” usufruirne, chi lavora in proprio, a cottimo, a Partita Iva, e quindi le ferie non sa nemmeno cosa siano. Restano le baby sitter a pagamento, che per tanti – o meglio tante – costano quanto il proprio stipendio mensile. Oppure i soliti nonni, che non è detto ci siano, siano vicini, siano disponibili o effettivamente in condizione di occuparsi dei nipoti per giorni e settimane. E, soprattutto, che in questa situazione sono proprio quelli che andrebbero tutelati al massimo, uscendo di casa il meno possibile ed evitando, magari, il contatto con nipoti e figli che potrebbero anche essere infetti senza saperlo.
Insomma, le problematiche legate alla gestione del lavoro quotidiano sono innegabili, oggettive e per qualcuno davvero pressanti, tanto da scatenare le immancabili faide social, inutili se non proprio controproducenti. Ed è altrettanto vero che per chi ha ricevuto la raccomandazione di non uscire di casa, mettere in fila un giorno dietro l’altro diventa in effetti una prova ardua. Ma non è solo questo, secondo me, che ci affligge in queste settimane di chiusura scolastica. La sensazione netta che ho io è che, oltre a preoccuparci comprensibilmente di come mandare avanti in qualche modo la baracca mentre i bambini sono a casa, oltre a patire laddove si debba restare per forza chiusi in casa, ci atterrisca la prospettiva in sé di passare intere giornate assieme ai nostri figli. Tanto che, salvo rare ma significative eccezioni, a “lamentarsi” e sentirsi messi a durissima prova sono anche i genitori che non lavorano, o quelli che sono a casa in ferie forzate. Quelli per i quali la conciliazione non è, o non è mai stata, un vero problema. Come se, al di là delle battute e dei meme, passare tante ore con i bambini che abbiamo messo al mondo fosse diventata un’esperienza non solo del tutto inusuale, ma anche estenuante, inaffrontabile. Distruttiva.
Fioccano tutorial, vademecum, menu settimanali, consigli su come impiegare il tempo in famiglia dentro casa, io stessa ho condiviso un vecchio post sulle attività da fare con i bambini piccoli. Eppure mi fa molto pensare, questa situazione (che in una certa misura riguarda anche la mia famiglia): quand’è che abbiamo smesso di ritenere “normale” passare tanto tempo con i nostri figli? Considerarla, non dico una cosa piacevole e appagante, ma quanto meno affrontabile e scontata? Com’è che abbiamo perso a tal punto la consuetudine di stare assieme a loro, che doverlo fare all’improvviso, per una causa di forza maggiore, ci coglie – noi ma forse anche i bambini stessi – impreparati, smarriti, in un certo senso inadeguati?
Nessuno nega, e ci mancherebbe, che occuparsi di uno o più figli per 24 ore al giorno, per settimane di fila, sia, per usare un blando eufemismo, molto stancante. Ma è, tecnicamente, quello che un genitore dovrebbe riuscire a fare, in ultima analisi. Quello per cui un genitore si definisce tale. E a mio parere c’è qualcosa da rivedere in una società che ha condotto i padri e le madri a non saperlo più fare, o a farlo di mala voglia, improvvisandosi, dovendo ricorrere ai consigli di blogger e canali YouTube. Una società in cui le famiglie si riducono a stare assieme solo perché è in corso un’epidemia di proporzioni planetarie.
Fanno ridere, e ben vengano, i meme, le battute, gli audio ironici che girano su WhatsApp su quanto sia distruttiva “per le madri” (perché i padri sono sempre ignorati, nella narrazione della genitorialità) la chiusura delle scuole. Ma forse questa, come tutte le crisi, è anche l’occasione per interrogarci su quello che siamo e su quello che vorremmo essere, sull’esistenza che ci viene consentito di condurre, sulle nostre priorità individuali e collettive. Chiederci se ci piace vivere in una società in cui il tempo per la propria vita e per la propria famiglia (quale che sia la sua composizione) viene sistematicamente sacrificato a quello per il lavoro e la produzione. Una società che ha trasformato i suoi membri in lavoranti a tempo pieno, che dal lavoro traggono non solo le risorse per vivere, ma anche la propria realizzazione, la reputazione pubblica e, in qualche caso, finanche la percezione definitiva di sé. Talmente poco avvezzi a passare del tempo coi loro stessi figli, da trovarsi in difficoltà quando finalmente ne hanno l’occasione.