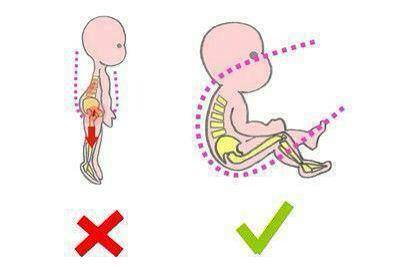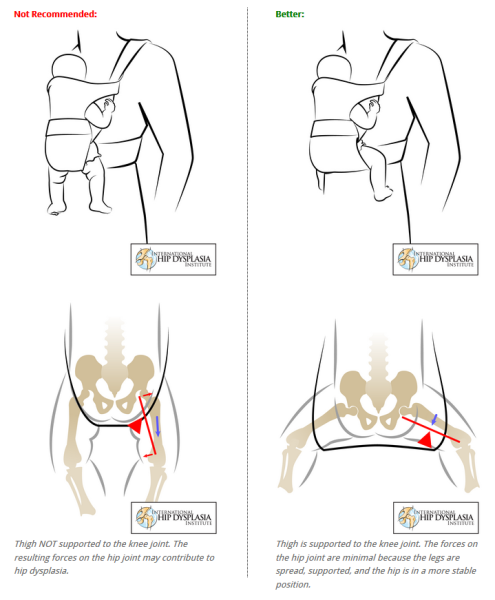Non la dimenticherò mai, la faccia di mio figlio nei suoi primi giorni di nido. La scrutavo colpevole quando tornavo a riprenderlo, seduta in mezzo a tante altre piccole facce sgomente, prima che lui mi riconoscesse sulla soglia. Era l’incarnazione perfetta dell’incredulità. Circondato da sconosciuti, sembrava chiedersi con disperazione perché mai sua madre lo avesse abbandonato in quel posto estraneo. Cosa fosse accaduto per condurlo in quell’incubo di solitudine e paura. Dietro a un ciuccio che si era fatto baluardo e casa, la faccia di mio figlio era nient’altro che una maschera di angoscia sorda, a cui, con i suoi piccoli 18 mesi, lui non sapeva dare voce né peso. Un’angoscia che tracimava dalla bocca e dagli occhi quando, finalmente, mi scorgeva nella cornice della porta, correndo verso di me con un misto di riconoscenza e di astio, di infinito sollievo e offesa insanabile.
Siamo andati avanti così per settimane, un’altalena estenuante di separazioni e ricongiungimenti. Una lacerazione quotidiana che causava insonnia, crisi di rabbia, panico e inediti digiuni. È stato il tempo dei dubbi, dei rimorsi. Dei confronti serrati alla ricerca di risposte – rassicuranti o infauste, poco importava. Il tempo della fatica e della pazienza. Ma anche del coraggio e della fiducia, della voglia di stare al suo fianco mentre affrontava un cambiamento di portata colossale.
Dio solo sa quante volte, mentre me lo strappavano a forza dalle braccia, sono stata sul punto di riprendermelo e correre via. Quante volte ho indugiato con la porta chiusa alle spalle, incerta sul da farsi. Quante lacrime ho ricacciato indietro per mostrargli, mentre lo affidavo a delle sconosciute, il più credibile dei sorrisi. Non saprei dire cosa mi abbia spinto ad aspettare, cosa mi abbia permesso di resistere e pazientare. Forse la calma apparente di suo padre, relativamente al sicuro dai tormenti dell’inserimento. Forse l’imminente arrivo di sua sorella, annuncio di impegno e di altre fatiche. Forse un indefinibile sesto senso, chi lo sa.
Ma il tempo mi ha restituito un figlio sorridente. Padrone di un territorio in cui io e suo padre siamo solo degli ospiti momentanei, proprietario entusiasta di una vita sociale che prescinde dalla sua casa e dalla sua famiglia. Protagonista di relazioni, riti e gesti che appartengono a lui e non a noi. Scorgere nei suoi giochi di ogni giorno frammenti sempre più riconoscibili delle attività quotidiane del nido è stata un’emozione crecente. Riuscire a riconoscere la melodia della sua canzone preferita, una sorpresa per tutti. Vederlo salutare le educatrici, riconoscere gli amici per strada, varcare sereno quella soglia ormai familiare, una liberazione e un orgoglio. Osservarlo mentre mi corre incontro ogni giorno col sorriso negli occhi, una gioia inestimabile.
Qualche settimana fa, suo padre mi ha chiamato per dirmi che nostro figlio era entrato al nido senza neanche voltarsi per salutarlo. Mentre parlava, percepivo nella sua voce un misto di fierezza e di malinconia che solo io potevo comprendere, e condividere. Una piccola gelosia felice, consapevolezza dolce e amara del tempo che è stato e di quello che è. La stessa che sento io ogni mattina, quando mio figlio, sventolandomi davanti il dorso della mano invece del palmo, mi dice “Ciao mamma” e si avvia con suo padre oltre la soglia di casa. Il nostro minuscolo bambino, così tormentato e così sensibile, ce l’ha fatta. E noi, forse, insieme a lui.